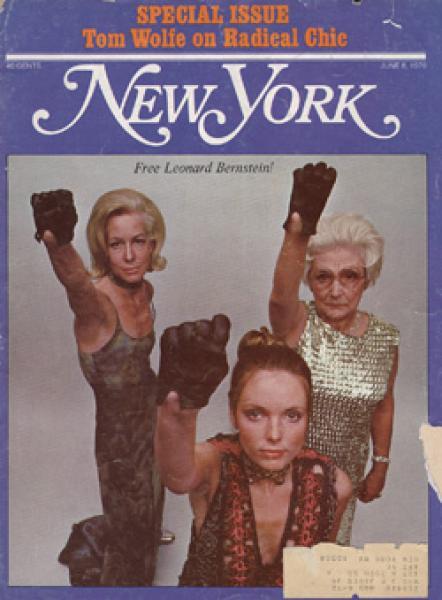A causa della frequenza con la quale in questi giorni viene evocata «la peste del Manzoni», mi pare doveroso tornare a riflettere su quanto accadde a Milano il primo giorno d’estate del 1630, quando alle prime luci del mattino una donna affacciata alla finestra avvista un uomo che sta camminando rasente al muro. La donna si chiama Caterina Rosa e non deve senz’altro ignorare che giù in strada diluvia, ma la scena alla quale assiste la insospettisce comunque. In città si dice che quattro francesi siano fuggiti da Madrid con l’accusa di spargere unguenti e l’attesa dei forestieri ha già comportato il pestaggio di tre turisti in visita al Duomo.
Così, mentre nel quartiere si diffonde la voce che qualcuno ha imbrattato i muri del corso, Caterina non esita a mettere nei guai il tipo con il cappello sugli occhi che ha spiato poche ore prima. L’uomo si chiama Guglielmo Piazza e fa un mestiere davvero maledetto, nella città appestata, dove i funzionari come lui diventano gli operatori di una violentissima ristrutturazione dei rapporti politici e sociali. Che li rende tre volte sospetti: perché il popolo ne patisce le disposizioni, perché il governo ne sorveglia l’operato e perché sono professionalmente esposti a entrare in contatto con l’epidemia, che potrebbero far circolare.
Una descrizione particolarmente accurata di questo triplice legame la forniscono le cronache della «grande peste» londinese redatte nel 1722 da Daniel Defoe, il quale racconta ciò che accadde quando l’infezione cominciò a minacciare la City. Fu solo in quel momento, infatti, che gli sceriffi assegnarono a ogni parrocchia un ispettore che avrebbe avuto il compito di vigilare sulle condizioni sanitarie dei singoli quartieri, mentre davanti alle case degli appestati, porta a porta, avrebbero stazionato «giorno e notte» due guardiani sotto la minaccia di «severi castighi». Alla base di questa «grande piramide del potere», come la definisce Michel Foucault, si sarebbero poi date da fare le donne addette all’ispezione dei cadaveri, soggette alla sorveglianza dei medici. Che a loro volta, scrive ancora Defoe, dovevano rispondere delle proprie azioni agli stessi ispettori che gli sceriffi minacciavano di severe sanzioni. Ciascuno sorvegliava e ciascuno veniva sorvegliato, insomma, impedendo ai timori per la propria sorte di averla vinta sul terrore instaurato dall’esecutivo.
Quello che l’epidemia può infatti favorire è «il momento meraviglioso nel quale il potere politico si esercita pienamente, (…) in cui la suddivisione di una popolazione viene portata al suo punto estremo, il momento in cui non si può più produrre alcuna comunicazione pericolosa, alcuna comunità confusa, alcun contatto proibito». Con parole diverse ma sempre di Michel Foucault, «il momento della peste è quello della suddivisione esaustiva di una popolazione da parte di un potere politico le cui ramificazioni capillari raggiungono senza interruzione la grana degli individui stessi, il loro tempo, il loro ambiente, la loro localizzazione, il loro corpo». Un momento che le circostanze rendono particolarmente instabile, è vero, ma comunque rivelatorio: un «sogno politico della peste» che assicura al potere la libera espressione di un’interiorità oscena.
Tra lo sceriffo di Londra e le singole abitazioni descritte da Defoe, si è dunque creato un rapporto diretto e lineare che vincola ciascuno al proprio ruolo, facendolo tuttavia dipendere da una catena di comando che rende quel sogno parzialmente incompleto. I funzionari (le ramificazioni di Foucault) potrebbero infatti sottrarsi a un compito che li obbliga a entrare continuamente in contatto con la minaccia di morte: è per questo che vengono ricattati ed è per questo che in alcuni casi faranno ugualmente perdere le loro tracce, come riferisce lo stesso Defoe.
Perché il comando possa davvero irrorare la «grana degli individui stessi», allora, bisognerà ricorrere a una forma di mobilitazione diversa, ancora più economica e totale. Ed è proprio così che Caterina Rosa e gli altri spettatori entrano di slancio sulla scena politica, per compendiare le pessime ragioni del potere con l’offerta di una sorveglianza integrale, che si apposta volontariamente ai davanzali. E creando un precedente al quale si potranno poi richiamare tutte le dittature, secondo Hannah Arendt, le quali si affermerebbero quando «un vicino di casa diventa a poco a poco un nemico più insidioso degli agenti ufficiali».
La «cattività» denunciata da Manzoni, la degenerazione dei tessuti sociali che si evidenzierebbe nelle scelte dei magistrati milanesi, tende a investire nel suo complesso lo statuto della cittadinanza, perché l’immoralità delle sentenze rinvia al terrore del «non trovar colpevoli» reso decisivo dalla presenza di un «pubblico». Caterina Rosa, dunque, la «spettatrice» che amministra la sua cambiale di potere dalla finestra di casa, l’autrice di un avvistamento dal quale dipenderanno le torture e il supplizio dei presunti colpevoli, questo personaggio della microstoria che sembrerebbe esaurirsi nella «superstizione» e nel «fanatismo» – è qualcosa di più.
Tanto per cominciare non si tratta di una singola signora che verso le quattro e mezzo del mattino inganna il tempo pattugliando la via che conduce alle colonne di San Lorenzo. In una prima redazione della Colonna infame non è neppure sola, ma entra immediatamente in scena al fianco di una comprimaria (Ottavia Boni) che nella stesura definitiva Manzoni deciderà di nominare altrove. A rendere più credibile la deposizione di Caterina, poi, contribuiscono alcune lavandaie, che una volta chiamate a fornire una perizia sul recipiente prelevato dal cortile del barbiere dichiarano di non avere dubbi: quell’acqua nasconde delle «furfanterie». E infine ci sono le consulenze di un medico e di due fisici che confermano la versione delle donne.
Perché accadeva infatti che «mentre le piaghe, i cadaveri a mucchi e i moribondi qua e là giacenti facevano inorridire – aveva scritto lo stesso cardinale Ripamonti ampiamente citato da Manzoni nel XXXII capitolo dei Promessi sposi – ed i morti commisti ai vivi tramutavano questa città in un solo sepolcro ed in un rogo, la pubblica calamità diveniva sempre più orrenda per gli odi intestini, l’esacerbazione degli animi, e il mostruoso sospetto che taluni, corrotti e venduti al demonio, a prezzo d’oro attendessero a disseminare la pestilenza. I congiunti medesimi e gli amici si schivavano; né si paventava solo il vicino e l’ospite come pericoloso, ma i genitori, il figlio, il fratello, il marito e la moglie, a cui uniscono i vincoli dell’affetto. Orribile e vergognoso a dirsi: la mensa, il talamo, e checché altro v’ha di santo per diritto di natura e delle genti, incuteva terrore, come se lì appunto s’appiattasse e si diffondesse il morbo. Trepidanti e con piè sospeso i cittadini giravano le strade, sopraffatti dalla paura de’ pestiferi unguenti».
Le stoviglie e i materassi risultano comunque infestati dal terrore, appiattando l’emergenza nelle incrinature dei rapporti più intimi e nella penombra dei soggiorni. Ed è per compiere un’ispezione altrettanto microscopica che dovranno aguzzare lo sguardo i sodali di Caterina, fin sotto le lenzuola, dove le indagini dei ministri, della «sbirraglia» o degli sceriffi finirebbero inevitabilmente col risultare più impopolari, oltre che impossibili.
E c’è da scommettere che lo faranno, che sospetteranno e che verranno sospettati, come spiega il presidente della commissione logistica in Cecità, il romanzo di Saramago. Il momento della storia è quello in cui il ministro fa notare che per trasferire i reclusi da un’ala all’altra del manicomio, dove vivono rispettivamente coloro che sono solo entrati in contatto con il «mal bianco» e i ciechi effettivi, ci sarà bisogno di obbligare i soldati a compiere un dovere che li espone al rischio di morte. Non sarà indispensabile, dice allora il presidente, perché «qualora uno dei sospetti diventi cieco, com’è naturale che succeda prima o poi, stia certo, signor ministro, che gli altri, coloro i quali hanno ancora la vista, lo metteranno fuori all’istante». Tanto che i prigionieri rimarranno rinchiusi nel manicomio anche quando non li obbligherà più nessuno, finché l’unica donna che non ha ancora perso la vista farà una scoperta sensazionale: «I soldati se n’erano andati».
Perché da un lato le prospettive di vita «si esprimono per così dire nella distanza dagli ammalati» e nella separazione dalla «massa di tutte le vittime», come ha scritto Elias Canetti, mentre dall’altro sono proprio questa distanza e questo distacco a comportare un nuovo «fenomeno di socializzazione» (è la tesi di Georges Didi-Huberman). A questo riguardo basti pensare come furono proprio le misure adottate dalle autorità medievali per fronteggiare la morte nera – con la creazione degli ispettorati sanitari, il registro dei decessi, la certificazione delle merci e il rilascio dei passaporti – a introdurre nel nord Italia e poi in tutta Europa una prima fase di modernizzazione. In Inghilterra, ha poi scritto Angelo Pastore, la grande peste avrebbe accelerato «il progressivo affermarsi delle esigenze del diritto di proprietà rispetto alla più antica concezione cristiana dei diritti naturali, che riconoscevano anche ai più poveri almeno il diritto alla vita». Ed è proprio qui, adesso, tra la vita dei mendicanti e le prerogative della proprietà, che si è introdotta la vigilanza di Caterina, rivendicando una funzione peculiare nella genealogia dei nuovi poteri che si stanno definendo nel corpo a corpo con l’epidemia.
Nella città allucinata dal desiderio politico della peste, infatti, dove chiunque viene abilitato a sorvegliare i comportamenti di un corrionale sospetto, fantasmatico e potenzialmente mortifero, la mobilitazione degli sguardi annuncia già lo stesso «rapporto sociale fra individui mediato dalle immagini» che si sarebbe consolidato nella società dello spettacolo. Nel capitolo dedicato alla programmazione del territorio, Debord osserva come in seguito all’isolamento prodotto dall’urbanismo, la produzione di immagini a mezzo di immagini e la loro circolazione abbiano reso comunque necessaria una forma di contatto e di integrazione tra gli individui separati, trasformandoli in «individui isolati insieme». Ed ecco allora che «le fabbriche come le case della cultura, i villaggi turistici come i grandi agglomerati, sono specificamente organizzati ai fini di questa pseudo-collettività che accompagna l’individuo isolato anche nella cellula familiare: l’impiego generalizzato dei ricevitori del messaggio spettacolare fa sì che il suo isolamento si ritrovi popolato delle immagini dominanti, immagini che per questo isolamento soltanto acquistano la loro piena potenza».
Nell’albero genealogico di questa «pseudo-collettività» non sarà difficile riconoscere le spettatrici di Manzoni, verso le quattro e mezza del mattino, alle prese con una rappresentazione segnaletica della pestilenza che le loro solitudini tenderanno inevitabilmente a rendere sempre più inclusiva e micidiale. Perché «l’immagine di quel supposto pericolo – aveva detto il narratore dei Promessi sposi – assediava e martirizzava gli animi molto più che il pericolo reale e presente» ed è questo fantasma del pericolo che gli animi martirizzati devono comunque porre al centro della loro paradossale coesione, la stessa che il governo della peste passerà in consegna al Panopticon di Jeremy Bentham e con la quale la folla «viene abolita in favore di un collezione di individualità separate», scrive appunto Foucault.
Questo rapporto tra separatezza e potenza delle immagini, si può chiarire attraverso i comportamenti della «pseudo-collettività» dei ciechi tra i quali Saramago decide di introdurre una radio, perché qualcuno possa ascoltare e riferire agli altri ciò che dice il notiziario. «Con parole sue riassumeva le informazioni e le trasmetteva ai più vicini – scrive Saramago. – Così, di letto in letto, le notizie facevano lentamente il giro della camerata, deformate a mano a mano che passavano da un ricevente al ricevente successivo, ridotta o aggravata in tal maniera l’importanza delle informazioni, secondo il personale grado di ottimismo e pessimismo di ogni emittente». E proprio come la fabbrica, i villaggi turistici o i grandi agglomerati forniranno una sintesi produttiva alla disarticolazione causata dal protagonismo delle merci, la socializzazione delle immagini oniriche che hanno consentito al potere di proiettare se stesso nel sogno della peste si produce nelle «pseudo-collettività» radunate intorno alla quarantena.
La quale sembrerebbe rinviare ai quaranta giorni di contumacia che nei periodi di pestilenza venivano imposti alle navi prima di entrare nei porti europei, sotto la stretta sorveglianza degli ispettori sanitari e rigorosamente all’ancora. Alla scadenza di quel periodo, dicevano gli esperti, qualunque tipo di sintomo si sarebbe fatto notare. Tuttavia risulta difficile credere che la latenza dei bubboni, in questo modo, non entrasse in risonanza con i quaranta giorni del diluvio universale, di Mosè sulla montagna, di Gesù nel deserto, la quaresima e l’ascensione, che dovevano fornire al provvedimento amministrativo la consistenza antropologica di una lotta finale contro il demonio. La peste rimarrà per molti secoli un segno della collera divina, anche, una punizione che il clero si candida a mitigare con una nuova e più minuziosa fenomenologia del peccato. La stessa corruzione dell’aria è soprattutto un problema di ordine morale, che si risolve con le penitenze e i pellegrinaggi, che non disdegna l’intervento dei santi e che dà libero sfogo alla persecuzione di prostitute, omosessuali ed ebrei.
La diffusione delle prime quarantene, infine, è contemporanea allo sforzo compiuto dalla chiesa per mettere a punto la dottrina del purgatorio, che del cosiddetto lazzaretto d’espurgo si direbbe quasi una variante teologica. Al di là della loro funzione temporale, dunque, è legittimo sospettare che ai quaranta giorni mutuati dalla medicina ippocratica fosse conferito un significato ideologico che attraverso la lingua – direbbe Gramsci – continua a infettare il nostro modo di convivere e di pensare.